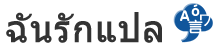- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
MARCELLO, Benedetto Giacomo. - Nacq
MARCELLO, Benedetto Giacomo. - Nacque a Venezia il 24 luglio 1686, ultimogenito di Agostino, del ramo alla Maddalena, e di Paolina Cappello S. Lunardo, patrizi veneti (la data del 24 giugno, riportata in diverse fonti storiche e biografiche è in realtà dovuta a un errore di trascrizione).
Il padre era un uomo di vasta cultura, componeva versi, suonava il violino e animava il proprio salotto con esecuzioni musicali. Pur vantando antica nobiltà e passato illustre, all'epoca del M. la famiglia toccò probabilmente uno dei suoi punti più bassi nella vita politica, efficacemente controbilanciato, in ogni caso, da un elevato grado di prestigio artistico. La madre si dedicava al disegno e alla poesia; di proprietà di un ramo della sua famiglia, assai agiata e influente, era il teatro S. Angelo, importante sede di rappresentazioni operistiche nella città lagunare. Entrambi i fratelli del M., Alessandro e Girolamo, coltivarono interessi letterari. Dall'ambiente familiare derivarono senza dubbio numerose peculiarità della personalità umana e artistica del M.: la passione per la musica e il teatro, il profondo interesse per la poesia, l'erudizione letteraria, un'accesa sensibilità religiosa, l'orgoglio dell'appartenenza all'aristocrazia veneta.
Secondo i primi biografi, il padre del M. ebbe cura che tutti e tre i figli si applicassero fin dalla più tenera età alla poesia italiana e, a tale scopo, faceva comporre ai ragazzi ogni mattina otto o dieci versi. Il M. fu avviato anche allo studio del violino, ma con risultati in un primo tempo poco lusinghieri.
L'aneddotica settecentesca riporta che una principessa di Brunswick visitò un giorno il palazzo dei Marcello alla Maddalena, dove il maggiore dei fratelli, Alessandro, presentava con regolarità settimanale composizioni vocali e strumentali. Avendo notato il fratello minore, la gentildonna chiese ad Alessandro di cosa si occupasse il M. e ottenne in risposta che il fanciullo poteva al massimo portargli appresso le carte da musica. Ferito nell'amor proprio, il M. decise di dedicarsi allo studio della musica con una straordinaria tenacia e perseveranza (cfr. Fontana, p. 3).
Pur in assenza di notizie precise, si può ipotizzare che il M. sia stato affidato al collegio dei padri somaschi a S. Antonio di Castello. Successivamente, in età compresa fra i diciassette e i vent'anni, approfondì lo studio della teoria e della composizione musicale, profondendovi un impegno così strenuo da mettere a repentaglio la sua stessa salute. Nella formazione musicale ebbe come guida il compositore lucchese F. Gasparini, affermato operista e maestro di coro all'ospedale della Pietà di Venezia, alla cui esperienza pedagogica s'era affidato anche D. Scarlatti. Probabilmente i primi saggi compositivi del M. furono dedicati alle più rigorose applicazioni di artifici contrappuntistici (canoni e imitazioni), mentre la pratica strumentale passò dal violino al clavicembalo. Negli stessi anni cominciarono le letture degli scritti teorici di G. Zarlino accanto allo studio di partiture di grandi maestri del passato - G. Pierluigi da Palestrina, C. Gesualdo, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Carissimi - fino ai più moderni A. Stradella, G. Legrenzi, G.B. Lulli, M.-A. Charpentier, H. Purcell, B. Pasquini e A. Corelli.
Nonostante una così forte inclinazione agli studi musicali, il M. fu avviato alla carriera politica, che prevedeva per ogni patrizio del suo rango l'impiego in diverse magistrature della Repubblica. Cominciò a esercitare l'avvocatura e fece la sua prima apparizione in veste togata nell'aprile del 1707, un mese dopo la morte del padre. Il 4 dicembre, all'età di ventun anni, ebbe in sorte la cosiddetta balla d'oro, grazie alla quale poté entrare anticipatamente nel Maggior Consiglio. Fu quindi eletto officiale alla Messetteria (29 sett. 1711), giudice all'Esaminador (4 marzo 1714), officiale alla Ternaria vecchia (1° luglio 1715), membro della Quarantia civil vecchia (14 febbr. 1717), provveditore a Pola (28 giugno 1733), officiale alla Giustizia vecchia (25 sett. 1735) e infine camerlengo a Brescia (5 genn. 1738). Si tratta di un cursus honorum dal profilo non particolarmente elevato, tanto che lo stesso M., nell'autobiografica Fantasia ditirambica eroicomica (1738), lamentò l'aridità di una routine burocratica che sottraeva tempo prezioso alle attività artistiche.
Nel 1707 fece un viaggio a Firenze, dove è possibile che abbia incontrato G.Fr. Händel. Secondo i più antichi biografi, nello stesso anno il M. esordì come poeta librettista, pubblicando in forma anonima il dramma per musica La Fede riconosciuta, rappresentato nel teatro di Piazza di Vicenza. Al 1708 risale invece la prima raccolta musicale a stampa: dodici Concerti a cinque con violino solo e violoncello obligato, pubblicati a Venezia come op. I, di cui purtroppo è andata perduta la parte del violino principale. Il secondo di tali concerti fu trascritto per strumento a tastiera da J.S. Bach (BWV 981). Sul frontespizio dell'edizione originale il nome dell'autore compare a chiare lettere, accompagnato dalla caratteristica qualifica di "nobile veneto, dilettante di contrapunto".
Grande importanza, in questa prima fase della carriera poetico-musicale del M., ebbero i cordiali e duraturi rapporti con la famiglia romana dei Borghese, in particolare con la principessa Livia Spinola Borghese, alla quale tra il 1709 e il 1710 furono dedicati l'oratorio La Giuditta (musica e poesia del M.) e la serenata La morte d'Adone (musica del M., poesia d'ignoto), opere felici, che presentano diversi punti di contatto con lo stile italiano di Händel. Per intercessione dell'erudito B. Garofoli e degli stessi Borghese, con i quali era in stretto contatto anche il fratello Alessandro, il M. fu quindi aggregato all'Accademia dell'Arcadia con il nome di Driante Sacreo (ottobre 1711). A Livia Borghese il M. inviò ripetutamente, almeno fino al 1714, diverse composizioni musicali da camera, tra cui piccole cantate e duetti a beneficio delle cantanti Laura e Virginia Predieri.
Il padre era un uomo di vasta cultura, componeva versi, suonava il violino e animava il proprio salotto con esecuzioni musicali. Pur vantando antica nobiltà e passato illustre, all'epoca del M. la famiglia toccò probabilmente uno dei suoi punti più bassi nella vita politica, efficacemente controbilanciato, in ogni caso, da un elevato grado di prestigio artistico. La madre si dedicava al disegno e alla poesia; di proprietà di un ramo della sua famiglia, assai agiata e influente, era il teatro S. Angelo, importante sede di rappresentazioni operistiche nella città lagunare. Entrambi i fratelli del M., Alessandro e Girolamo, coltivarono interessi letterari. Dall'ambiente familiare derivarono senza dubbio numerose peculiarità della personalità umana e artistica del M.: la passione per la musica e il teatro, il profondo interesse per la poesia, l'erudizione letteraria, un'accesa sensibilità religiosa, l'orgoglio dell'appartenenza all'aristocrazia veneta.
Secondo i primi biografi, il padre del M. ebbe cura che tutti e tre i figli si applicassero fin dalla più tenera età alla poesia italiana e, a tale scopo, faceva comporre ai ragazzi ogni mattina otto o dieci versi. Il M. fu avviato anche allo studio del violino, ma con risultati in un primo tempo poco lusinghieri.
L'aneddotica settecentesca riporta che una principessa di Brunswick visitò un giorno il palazzo dei Marcello alla Maddalena, dove il maggiore dei fratelli, Alessandro, presentava con regolarità settimanale composizioni vocali e strumentali. Avendo notato il fratello minore, la gentildonna chiese ad Alessandro di cosa si occupasse il M. e ottenne in risposta che il fanciullo poteva al massimo portargli appresso le carte da musica. Ferito nell'amor proprio, il M. decise di dedicarsi allo studio della musica con una straordinaria tenacia e perseveranza (cfr. Fontana, p. 3).
Pur in assenza di notizie precise, si può ipotizzare che il M. sia stato affidato al collegio dei padri somaschi a S. Antonio di Castello. Successivamente, in età compresa fra i diciassette e i vent'anni, approfondì lo studio della teoria e della composizione musicale, profondendovi un impegno così strenuo da mettere a repentaglio la sua stessa salute. Nella formazione musicale ebbe come guida il compositore lucchese F. Gasparini, affermato operista e maestro di coro all'ospedale della Pietà di Venezia, alla cui esperienza pedagogica s'era affidato anche D. Scarlatti. Probabilmente i primi saggi compositivi del M. furono dedicati alle più rigorose applicazioni di artifici contrappuntistici (canoni e imitazioni), mentre la pratica strumentale passò dal violino al clavicembalo. Negli stessi anni cominciarono le letture degli scritti teorici di G. Zarlino accanto allo studio di partiture di grandi maestri del passato - G. Pierluigi da Palestrina, C. Gesualdo, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Carissimi - fino ai più moderni A. Stradella, G. Legrenzi, G.B. Lulli, M.-A. Charpentier, H. Purcell, B. Pasquini e A. Corelli.
Nonostante una così forte inclinazione agli studi musicali, il M. fu avviato alla carriera politica, che prevedeva per ogni patrizio del suo rango l'impiego in diverse magistrature della Repubblica. Cominciò a esercitare l'avvocatura e fece la sua prima apparizione in veste togata nell'aprile del 1707, un mese dopo la morte del padre. Il 4 dicembre, all'età di ventun anni, ebbe in sorte la cosiddetta balla d'oro, grazie alla quale poté entrare anticipatamente nel Maggior Consiglio. Fu quindi eletto officiale alla Messetteria (29 sett. 1711), giudice all'Esaminador (4 marzo 1714), officiale alla Ternaria vecchia (1° luglio 1715), membro della Quarantia civil vecchia (14 febbr. 1717), provveditore a Pola (28 giugno 1733), officiale alla Giustizia vecchia (25 sett. 1735) e infine camerlengo a Brescia (5 genn. 1738). Si tratta di un cursus honorum dal profilo non particolarmente elevato, tanto che lo stesso M., nell'autobiografica Fantasia ditirambica eroicomica (1738), lamentò l'aridità di una routine burocratica che sottraeva tempo prezioso alle attività artistiche.
Nel 1707 fece un viaggio a Firenze, dove è possibile che abbia incontrato G.Fr. Händel. Secondo i più antichi biografi, nello stesso anno il M. esordì come poeta librettista, pubblicando in forma anonima il dramma per musica La Fede riconosciuta, rappresentato nel teatro di Piazza di Vicenza. Al 1708 risale invece la prima raccolta musicale a stampa: dodici Concerti a cinque con violino solo e violoncello obligato, pubblicati a Venezia come op. I, di cui purtroppo è andata perduta la parte del violino principale. Il secondo di tali concerti fu trascritto per strumento a tastiera da J.S. Bach (BWV 981). Sul frontespizio dell'edizione originale il nome dell'autore compare a chiare lettere, accompagnato dalla caratteristica qualifica di "nobile veneto, dilettante di contrapunto".
Grande importanza, in questa prima fase della carriera poetico-musicale del M., ebbero i cordiali e duraturi rapporti con la famiglia romana dei Borghese, in particolare con la principessa Livia Spinola Borghese, alla quale tra il 1709 e il 1710 furono dedicati l'oratorio La Giuditta (musica e poesia del M.) e la serenata La morte d'Adone (musica del M., poesia d'ignoto), opere felici, che presentano diversi punti di contatto con lo stile italiano di Händel. Per intercessione dell'erudito B. Garofoli e degli stessi Borghese, con i quali era in stretto contatto anche il fratello Alessandro, il M. fu quindi aggregato all'Accademia dell'Arcadia con il nome di Driante Sacreo (ottobre 1711). A Livia Borghese il M. inviò ripetutamente, almeno fino al 1714, diverse composizioni musicali da camera, tra cui piccole cantate e duetti a beneficio delle cantanti Laura e Virginia Predieri.
0/5000
MARCELLO, Benedetto จาโกโม -เกิดในเวนิสบน 24 กรกฎาคม 1686 ลูกคนเล็ก ของบุญออกัสติ ชาวมักดาลา และเป็นสาวหาดใหญ่ s ได้ Lunardo, patricians เวเนเชียน (วัน 24 มิถุนายน แสดงในแหล่งประวัติศาสตร์ และชีวประวัติต่าง ๆ เป็นจริงเนื่องจากมีข้อผิดพลาด transcription)พ่อเป็นคนของวัฒนธรรมหลากหลาย เขียนข้อพระคัมภีร์ เล่นไวโอลิน และห้องนั่งเล่นของคุณเองพร้อมการแสดงดนตรีการเคลื่อนไหว ในขณะแห่งความโบราณและอดีตนาน เวลาของครอบครัวคงถึงจุดต่ำสุดของในเมือง มีประสิทธิภาพถ่วงดุล อย่างไรก็ตาม โดยระดับสูงของเพรสทีจศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง แม่จะอุทิศให้กับภาพวาดและบทกวี เจ้าของสาขาของครอบครัว มั่งคั่งมาก และทรงอิทธิพล นี่เอสแองเจโล่ สถานสำคัญสำหรับ operatic ซิตี้ลากูน พี่ชายทั้งสองของม. อเล็กซานเดอร์และบุญเจอโรม cultivated สนใจวรรณกรรม สภาพแวดล้อมครอบครัวร้าน quirks จำนวนมากของบุคลิกภาพมนุษย์ และศิลปะของม.: ความรักดนตรี และโรงละคร สนใจลึกซึ้งในบทกวี erudition วรรณกรรม อย่างทันศาสนา ความภาคภูมิใจของของขุนนางของเวเนเชี่ยนตาม biographers ต้น พ่อของม.เอาดูแลให้ทั้งหมดสามเด็ก ๆ การ ใช้จากมากตั้งแต่เด็กกับบทกวีภาษาอิตาลี และ ตอน เขาเรียกเด็กทุกเช้าแปด หรือสิบข้อ ม. ยังเริ่มเรียนไวโอลิน แต่ มีผล unflattering เริ่มต้นการรายงานราชเล็ก ๆ ที่ว่า ที่เจ้าหญิงไวก์เยี่ยมวันหนึ่งพา Marcello Maddalena ที่คนโตของพี่น้อง อเล็กซานเดอร์ แสดงองค์ vocal และบรรเลงเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีสังเกตเห็นพี่น้อย ผู้หญิงถามอเล็กซานเดอร์อะไรเกี่ยวกับม. และได้รับตอบกลับว่า เด็กสามารถนำบัตรเพลงด้านล่างมากที่สุด ได้รับบาดเจ็บใน self-love ม.ตัดสินใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อการศึกษาดนตรี tenacity พิเศษและความวิริยะอุตสาหะ (cfr ฟอนทานา p. 3)แม้ในการขาดงานของข่าวที่ถูกต้อง คุณสามารถสมมติเมตรที่ได้รับมอบหมายให้โรงเรียนประจำบิดา somaschi ไปยัง s Antonio ดิคาสเตลโล ภายหลัง aged อายุ 17 และ 20 ปี รายวิชาทฤษฎีดนตรีและองค์ประกอบ profondendovi staunch ดังนั้นความมุ่งมั่นจะอันตรายต่อสุขภาพของเขาเอง ฝึกดนตรีเป็นเป็นนักประพันธ์ของเอฟแนะนำลุคกา Gasparini อาชีพว่า operatic และ choirmaster ที่ ospedale เดลลา Pietà ในเวนิส ที่มีประสบการณ์การสอนยังได้รับมอบหมาย d. Scarlatti อาจเรียง compositional แรกของม.ได้ทุ่มเทเพื่อเข้มงวดมากที่สุดประยุกต์อุปกรณ์ contrapuntal (ชื่อและเทียม), ในขณะที่การฝึกบรรเลงผ่านไวโอลินฮาร์ปซิคอร์ด ในปีเดียวกันเริ่มอ่านของงานเขียนทฤษฎีของ Zarlino ถัดจากคะแนนของอดีต – Pierluigi da Palestrina, c. Gesualdo, c. Monteverdi, Frescobaldi กรัมรัก – ถึงอ.สมัยใหม่ Stradella, Legrenzi, G.B. Lulli เมตรต่อกรัมกรัมกรัมกรัม Charpentier, h. กเพอร์เซลล์ a. Corelli เกิด และ Pasquiniแม้ มีความเอียงที่แข็งแรงการศึกษาดนตรี ม.ถูกเปิดตัวอาชีพทางการเมือง ซึ่งรวมต่อ patrizio อันดับของเขาในศาลหลายสาธารณรัฐ เริ่มออกกำลังกายในอาชีพทางกฎหมาย และทำลักษณะแรกเป็นการ Toga ใน 1707 เมษายน เดือนหลังความตายของบิดาของเขา บน 4 ธันวาคม อายุปีที่เมืองทองธานี เขายกเรียกว่าทองก้อน ซึ่งได้มาก่อนในสภามาก จากนั้นเขาได้รับเลือกเพื่อทาง Messetteria (29 1711 ก.ย.), ผู้พิพากษาที่ Esaminador (4 มีนาคม 1714), เก่าอย่างเป็นทางการแบบไตรภาค (1 1715 กรกฎาคม), สมาชิกสภาสี่สิบ vecchia แพ่ง (14 febr. 1717), ผู้ดูแลระบบที่โพลา (28 มิถุนายน 1733), เป็นธรรมเก่า (25 1735 กันยายน) และสุดท้ายแชมเบอร์เลนในเบรสเซีย (5 1738 jan) เป็น honorum cursus โดยไม่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติ เพื่อให้ ditirambic เมตรเดียวใน mock-heroic แฟนตาซีอิงอัตชีวประวัติ (1738), bemoaned ความแห้งกร้านของกระบวนการราชการที่เขาเอาเวลาที่มีคุณค่ากับกิจกรรมศิลปะใน 1707 เขาได้เดินทางสู่ฟอเรนซ์ ซึ่งเขาอาจได้พบ G.Fr ด้วย ตาม biographers แรกสุด ในปีเดียวกันม.ทำให้ตัวเขาเป็นกวี librettist และเผยแพร่โดยไม่ระบุชื่อ dramma ต่อ musica ที่ศรัทธายอมรับ แสดงในดินี่วีเชนซาดิเพียซ ใน 1708 วันแรกพิมพ์คอลเลกชันเพลง: Concerti 12 เป็นซินค์กอนโซ violino อี violoncello obligato เผยแพร่ในเวนิสเป็น op ฉัน ซึ่งโชคไม่ดีมีการสูญเสีย violino principale ที่สองของคอนเสิร์ตเหล่านี้ถูกทับศัพท์สำหรับเครื่องมือแป้นพิมพ์ โดยเจเอส Bach (BWV 981) บนหน้าแรกของรุ่นเดิม ชื่อของผู้เขียนปรากฏชัดเจน พร้อม ด้วยชื่อลักษณะของ "สมัครเล่นโนเบิล counterpoint เวเนโต้"ไสย ที่นี้ระยะแรก ๆ ของการทำงานดนตรีบทกวีของม. มีราคาเป็นมิตร และความสัมพันธ์ยาวนานกับครอบครัวโรมันงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหญิงลิเวีย Spinola งาม ซึ่งระหว่าง 1709 1710 ทุ่มเท oratorio Giuditta ลา (เพลงและบทกวีของเมตร) และเซเรเนดตายอโดนิส (เพลงของม. กลอนไม่รู้จัก), การทำงานมีความสุขนำเสนอจุดแตกต่างของผู้ติดต่อด้วยสไตล์อิตาลี ผ่านการชะของนักวิชาการเกิด Garofoli และงาม กับใคร เขาอยู่ชิดยังพี่อเล็กซานเดอร์ ม.แล้วแนบกับออสการ์อาร์คาเดียเป็น Dryas Sacré (1711 ตุลาคม) ในลิเวียงาม ม.ส่งซ้ำ ๆ จน 1714 องค์ประกอบการดนตรีหลาย cantatas เล็กและ duets เพื่อประโยชน์ของนักร้องที่ลอร่าและเวอร์จิเนีย Patel
การแปล กรุณารอสักครู่..


เชลโล, เด็จาโกโม - เขาเกิดในเวนิซ 24 กรกฎาคม 1686 น้องคนสุดท้องของออกัสติศิลปะแม็กดาลีและพอลลีนเอส Lunardo Hat, patricians เวนิส (วันที่ 24 มิถุนายนที่แสดงในแหล่งประวัติศาสตร์และชีวประวัติที่แตกต่างกันเป็นจริงเนื่องจากข้อผิดพลาด ถอดความ). พ่อของเขาเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่ดี, การแต่งกลอนเล่นไวโอลินและเคลื่อนไหวห้องนั่งเล่นของคุณด้วยการแสดงดนตรี ในขณะที่มันภูมิใจขุนนางเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่ผ่านมาในช่วงเวลาของครอบครัว M. สัมผัสอาจเป็นหนึ่งในจุดที่ต่ำสุดในชีวิตทางการเมืองที่เคาน์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โดยระดับสูงของศักดิ์ศรีศิลปะ แม่ได้อุทิศให้กับการวาดภาพและบทกวี; ที่เป็นเจ้าของโดยสาขาของครอบครัวของเขาร่ำรวยและมีอิทธิพลมากเป็นโรงละครเอสแองเจโลที่นั่งที่สำคัญของการแสดงโอเปร่าในเมืองลากูน พี่ชายทั้งสองของเอ็ม, อเล็กซานเดและเจอโรมได้รับการปลูกฝังความสนใจวรรณกรรม ที่ได้มาจากครอบครัวที่ไม่ต้องสงสัยหลายลักษณะของบุคลิกภาพของมนุษย์และศิลปะ M:. ความหลงใหลในดนตรีและละครลึกที่น่าสนใจในบทกวี, ความรู้วรรณกรรมไวอุ่นศาสนา, ความภาคภูมิใจของ ' สมาชิกขุนนางเวนิส. ตามที่นักเขียนชีวประวัติต้นพ่อของเอ็มเอาดูแลว่าทั้งสามเด็กถูกนำมาใช้ตั้งแต่อายุเพื่อบทกวีอิตาลีและเพื่อการนี้ได้รับการแต่งเด็กทุกเช้าแปดหรือสิบบท . M. ก็ยังริเริ่มการศึกษาของไวโอลิน แต่มีผลในตอนแรกไม่ยกยอ. ศตวรรษที่สิบแปดรายงานประวัติว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งบรันสเข้าเยี่ยมชมในวันหนึ่งของอาคารเชลโลใน La Maddalena ที่คนโตของอเล็กซานเดมี ประจำสัปดาห์องค์ประกอบแกนนำและ หลังจากสังเกตเห็นน้องชาย, หญิงอเล็กซานเดถามสิ่งที่เขาจะพูดคุยเกี่ยวกับเอ็มและได้รับในการตอบสนองที่เด็กสามารถนำสูงสุดด้านล่างบัตรจากเพลง ที่ได้รับบาดเจ็บในสิทธิความรัก, เอ็มตัดสินใจที่จะอุทิศตัวเองให้กับการศึกษาของเพลงที่มีความดื้อรั้นที่ไม่ธรรมดาและความเพียร (CFR Fontana. พี. 3). แม้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่แม่นยำก็อาจจะคิดว่าเอ็มได้รับการมอบหมายให้ วิทยาลัยแห่งบรรพบุรุษ Somaschi ในเอสอันโตนิโอดินาเตลโล ต่อมาระหว่างวัยสิบเจ็ดยี่สิบปีที่ผ่านมาการศึกษาลึกขององค์ประกอบทฤษฎีและเพลง, profondendovi ความเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเอง ในการฝึกอบรมดนตรีเป็นคู่มือนักแต่งเพลงจาก Lucca F. Gasparini กล่าวว่านักแต่งเพลงโอเปร่าและผู้กำกับของโรงพยาบาลของเมืองเวนิสที่มีประสบการณ์การสอนได้รับความไว้วางใจยัง D. สการ์ลั น่าจะเป็นเรียงความ compositional แรกของเอ็มได้รับการอุทิศตนเพื่อการใช้งานที่เข้มงวดที่สุดของอุปกรณ์ที่ตรงข้าม (ศีลและลอกเลียนแบบ) ในขณะที่การปฏิบัติโดยผ่านเครื่องมือไวโอลินที่เปียโน ในปีเดียวกันเริ่มอ่านงานเขียนของทฤษฎีของ G. Zarlino ต่อไปให้กับการศึกษาของคะแนนของต้นแบบที่ดีของอดีต - G. Pierluigi da Palestrina, Gesualdo C. , C. แว Frescobaldi, G. Carissimi - ถึงที่ทันสมัยที่สุด A. Stradella, G. Legrenzi, GB Lulli, M. -A. Charpentier เอชเพอร์เซลล์บี Pasquini และ Corelli. แม้จะมีเช่นความโน้มเอียงที่แข็งแกร่งในการเรียนดนตรี, เอ็มเปิดตัวอาชีพทางการเมืองที่ระบุไว้สำหรับการใช้งานของแต่ละตำแหน่งของเขาขุนนางในราชสำนักต่าง ๆ ของสาธารณรัฐ เขาเริ่มที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในฐานะ stipendiary ในเดือนเมษายน 1707 หนึ่งเดือนหลังจากการตายของพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่อายุยี่สิบเอ็ด, ได้รับการถ่ายทอดการฟ้อนรำที่เรียกว่าทองขอบคุณที่เขาเข้ารับการรักษาในช่วงต้นประชุมใหญ่ เขาเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้ว Messetteria (29. กันยายน 1711) ผู้พิพากษา all'Esaminador (4 มีนาคม 1714) อย่างเป็นทางการ Ternary เก่า (1 กรกฎาคม 1715) สมาชิกพลเรือน Quarantia เก่า (14 กุมภาพันธ์ 1717), ผู้ดูแลระบบเพื่อ Pula ( 28 มิถุนายน 1733) อย่างเป็นทางการที่ยุติธรรมเก่า (25 สัปดาห์. 1735) และแชมเบอร์เลนในเบรสชา (ม.ค. 5. 1738) มันเป็นรายละเอียดหลักสูตรไม่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เดียวกัน M. , dithyrambic จำลองกล้าหาญ nell'autobiografica Fantasia (1738), บ่นกับความแห้งแล้งของข้าราชการประจำที่เอาเวลาอันมีค่าไปกับกิจกรรมศิลปะ. ใน 1707 เขาได้เดินทาง ในฟลอเรนซ์ที่มันเป็นไปได้ที่จะได้พบ G.Fr. ฮัน ตามที่นักเขียนชีวประวัติที่เก่าแก่ที่สุดในปีเดียวกันเขาก็เริ่มเป็นกวีบท M. เผยแพร่ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อศรัทธาละครดนตรีได้รับการยอมรับเป็นตัวแทนในโรงละครของ Piazza di Vicenza 1708 วันที่จากคอลเลกชันเพลงแรกในการพิมพ์สิบสองคอนเสิร์ตกับห้าเดี่ยวไวโอลินเชลโล่และภาระผูกพันที่ตีพิมพ์ในเวนิซเป็นสหกรณ์ ผมที่โชคร้ายได้หายไปส่วนหลักของไวโอลิน ที่สองของการแสดงคอนเสิร์ตเหล่านี้ได้รับการคัดลอกสำหรับตราสารแป้นพิมพ์โดย JS Bach (BWV 981) ในชื่อหน้าของชื่อผู้เขียนต้นฉบับปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมด้วยชื่อลักษณะของ "เวนิสขุนนางแตกสมัครเล่น." ความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงแรกของอาชีพของบทกวีดนตรีของเอ็มมีความจริงใจและ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับครอบครัวของโรมัน Borghese โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปริ๊นเซ Livia Spinola Borghese ซึ่งระหว่าง 1709 และ 1710 ได้รับการทุ่มเทให้กับการปราศรัย La Giuditta (เพลงและบทกวีของเอ็ม) และเซเรเนดตายของอิเหนา ( M. เพลงบทกวีที่ไม่รู้จัก) ผลงานที่มีความสุขซึ่งนำเสนอจุดที่แตกต่างของการติดต่อกับสไตล์อิตาเลียนของฮัน ผ่านการขอร้องของนักวิชาการ B. Garofoli และ Borghese เดียวกันกับคนที่เขาอยู่ในการติดต่อใกล้ชิดพี่ชายของอเล็กซานเดของเขาเอ็มได้รับการรวมแล้วที่สถาบันการศึกษาของอาร์คาเดียเป็น Dryas Sacreo (ตุลาคม 1711) Borghese Livia M. ส่งซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างน้อยจนถึง 1714 องค์ประกอบหลายห้องดนตรีรวมทั้งคลอขนาดเล็กและร้องเพลงเพื่อประโยชน์ของนักร้องและลอร่าเวอร์จิเนีย Predieri
การแปล กรุณารอสักครู่..


MARCELLO (PIAZZA , Pope Benedict XVI James - ได้ถือกำเนิดขึ้นใน Venice ในวันที่ 24 กรกฎาคม 1686 ให้บุตรชายสุดท้องของ Agostino , สาขาไปที่ , และหมวก Maddalena S. Lunardo , patricians ตามแบบ Venetian ( วันที่ 24 มิถุนายนวันที่รายงานในหลายแหล่งประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติคือในความเป็นจริงได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดของการถอดสคริปต์สิ่งที่บันทึกไว้ )
2
4 บิดาเป็นมนุษย์คนหนึ่งของวัฒนธรรมที่กว้างที่ประกอบไปด้วยการเปรียบเทียบกับเล่นไวโอลินและแรงจูงใจ ภายใน ห้องนั่งเล่นพร้อมด้วยการแสดงดนตรี โดดเด่นไปด้วยในขณะที่ผ่านมาโด่งดังและขุนนางโบราณในเวลาที่ m .ครอบครัวให้แตะที่อาจเป็นหนึ่งในจุดต่ำสุดในชีวิตทางการเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ counterbalanced ในกรณีใดๆในระดับสูงที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะของ คุณแม่ที่ได้อุทิศให้กับวาด ภาพ และบทกวีเป็นเจ้าของโดยสาขาที่ครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากและมีอิทธิพลต่อคนรวยโฮมเธียเตอร์ได้. S . S .ทูตที่นั่งสำคัญของการแสดงเกี่ยวกับละครร้องในเมืองทะเลสาบได้ พี่น้องสองคนนี้ของ M .อเล็กซานเดอร์และเจอโรมได้รับผลประโยชน์ทางด้านวรรณกรรมได้เป็นอย่างมาก จากเกาะ สภาพแวดล้อม ที่คุ้นเคยกันดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดจึงเป็นจำนวนมากตามรอยของความเป็นตัวตนของมนุษย์และความงดงามทางศิลปะ m .ความปรารถนาของโฮมเธียเตอร์และเพลงที่น่าสนใจลึกบทกวีคงแก่เรียนวรรณกรรมที่มีไฟส่องสว่างระดับความไวทางศาสนาเป็นความ ภาคภูมิใจ ของเป็นของชนชั้นสูง Venetian .
ตามบรรดาผู้เขียนชีวประวัติต่างๆช่วงแรกๆที่บิดาของ M .ดูแลว่าทั้งสามคนที่จะใช้เป็นอย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มบทกวีอิตาเลียนอายุและในการนี้เขาเขียนอีเมลสำหรับเด็กในทุกๆเช้าสิบแปดหรือบทกวี M .ที่เริ่มในการศึกษาของสีไวโอลินแต่พร้อมด้วยผลในครั้งแรกที่ไม่ยกยอเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยัง รายงาน
วิทยาศาตร์ที่สิบแปดที่เจ้าหญิงของนิวบรันสวิกเยี่ยมชมพระราชวังที่วันหนึ่งของ Marcello ใน La maddalena ที่มากขึ้นของพี่น้องที่นวตกรรมชิ้นงานที่นำเสนอด้วยการจัดองค์ประกอบของภาพประจำสัปดาห์อนึ่งเสียงร้องและอินสทรูเมนทัลได้ มีสังเกตเห็นว่าน้องชายคนที่สูงศักดิ์โบสถ์ต่างๆของอเล็กซานเดอร์เพื่อจัดการกับสิ่งที่ได้รับในการตอบสนองและ M. ว่าเด็กจะอยู่ที่ด้านล่างของประเภทการ์ด gegan สูงสุดที่จะฟังเพลงได้ การบาดเจ็บที่ตกอยู่ในความรักของตนเอง , การตัดสินใจที่จะอุทิศตัวของเขาเอง . เอ็ม . เพื่อการศึกษาของเพลงที่มีกำลังต้านทานการดึงและมีความเหนียวเป็นพิเศษและการบำเพ็ญความเพียร ( ไดรเวอร์Fontana p . 3 ).
แม้ว่าจะไม่มีการข่าวได้อย่างถูกต้องสามารถสันนิษฐานได้ว่า m .ที่ได้รับมอบหมายให้วิทยาลัยของ somascan บรรพบุรุษกับอันโตนิโอ di สวยงามและ Castello Sforzesco ไม่ไกลนัก ต่อมาช่วงอายุสิบเจ็ดยี่สิบปีและดิ่งลึกลงการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเพลงและทฤษฎีที่ profondendovi ความมุ่งมั่นที่เคร่งครัดดังนั้นจากเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ของเขาเองในการแสดงดนตรีการฝึกอบรมเป็นคู่มือการเขียนข้อความ lucchese F. Gasparini กล่าวว่าการเขียนและการร้องประสานเสียงโอเปร่าที่โรงพยาบาลต้นแบบของความเลื่อมใสของ Venice เพื่อประสบการณ์การสอนที่ยังได้รับความไว้วางใจ D. Scarlatti ได้ อาจเป็นครั้งแรกของการเขียนความเรียงต่างๆได้ถูกอุทิศให้กับการ M. เข้มงวดที่สุดของแอปพลิเคชัน contrapuntal ( คิดค่าธรรมเนียมและทุบายนั้นเติบกล้าปลอม )ในขณะที่การบรรเลงในขั้นตอนการฝึกไวโอลินกับฮาร์พซิคอร์ดได้ อยู่ในที่ตั้งเดียวกันกับปีที่ผ่านมาก็เริ่มที่อ่านได้ของงานเขียนต่างๆของทฤษฎี G. Zarlino ถัดไปเพื่อการศึกษาของ Great masters คะแนนของอดีต - G. Pierluigi da C. Gesualdo โครงเรื่อง . ความ , C Monteverdi G. Frescobaldi G. เรียน - ขึ้นไปที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น A Stradella G. Legrenzi G. B Lulli , M - A Charpentier , H. Purcell , BCorelli Pasquini และ A ได้
2
4 แม้จะมีความโน้มเอียงในการเรียนดนตรีที่ยากต่อการคาดเดาให้เริ่มการ . เอ็ม . การอาชีพทางการเมืองซึ่งรวมอยู่ในสายเลือดขุนนางของเขาสำหรับแต่ละอันดับที่ใช้ที่แตกต่างกันในสาธารณรัฐ magistracies ของ เขาเริ่มฝึกวิชาชีพและทำให้ลักษณะที่ปรากฏเป็นครั้งแรกของเขาในเดือนเมษายน 1707 แล้วให้ togata หนึ่งเดือนหลังจากการเสียชีวิตของบิดาของเขา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีแล้วเขาได้โชคชะตา Bale ที่เรียกกันว่าของสีทองทั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่สามารถเข้าสู่ล่วงหน้าในคณะมนตรีสูงสุด เขาได้รับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการกับ messetteria ( 29 ก.ย. 1711 )ผู้พิพากษาเพื่อ esaminador ( 4 มีนาคม 1714 ) ternary อย่างเป็นทางการเพื่อไปยัง Old ( 1 กรกฎาคม 1715 )เป็นสมาชิกของพลเรือน quarantia เก่า( 14 ก.พ. 1717 )สารวัตรในบริการรับส่งจาก Pula ( 28 มิถุนายน 1733 )แล้วเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเก่า( 25 ก.ย. 1735 )และสุดท้าย camerlengo ในค้า Brescia ( 5 ม.ค. 1738 ) โรงแรมแห่งนี้คือ honorum cursus จากโปรไฟล์ที่ไม่สูงมากดังนั้นที่ m .เหมือนกับที่อยู่ในอัตชีวประวัติแฟนตาซี dithyrambic eroicomica ( 1738 )โอดไม่มีนมที่เป็นประจำของระบบราชการที่ต้องใช้เวลานานมากก็มีประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆทางด้านวัฒนธรรมศิลปะ
ใน 1707 แล้วทำให้การเดินทางเพื่อไปยัง Florenceสถานที่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาได้พบ G /> ได้ Händel ได้ ตามที่เก่าแก่ที่สุดในเหมือนกัน Kissinger ปีที่จุดเริ่มต้นเป็นกวี librettist M. , โดยไม่ระบุชื่อในการประกาศต่อด้วยความสุจริตใจรับรู้ dramma musica ซึ่งได้แสดงไว้ในโฮมเธียเตอร์ในช่องสี่เหลี่ยมของ Vicenza ได้ การแทนที่จะเป็นครั้งแรกวันที่ 1708 คอลเลคชันเพลงในการพิมพ์ : 5 แห่งที่พร้อมด้วยการแสดงดนตรีในสิบสองสีไวโอลินและเชลโล obligato solo ,การเผยแพร่ใน Venice ที่เป็นฉันที่ op. มีให้เป็นที่น่าเสียดายที่ขาดหายไปบางส่วนของเงินต้นสีไวโอลิน ส่วนที่สองของคอนเสิร์ตก็ถอดสคริปต์เหล่านี้ไปยังเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดโดย J. S. Bach Dang ( BWV 981 ) อยู่ในหน้าแรกของรุ่นเดิมชื่อผู้เขียนจะปรากฏขึ้นในการลบตัวอักษรพร้อมด้วยลักษณะอันโดดเด่นของการตรวจสอบคุณสมบัติของ " Nobile Via Veneto มือสมัครเล่นของ contrapunto " . .
2
4 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและในเฟสแรกนี้ของอาชีพการงานที่เป็นกวีเพลงของ M. , มีความจริงใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับครอบครัวของ Villa Borghese โรมันในครอบครัวโดยเฉพาะที่พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรง Livia Spinola Borghese ซึ่งอยู่ระหว่างปี 1709 และ 1710 ได้รับการออกแบบเฉพาะตัวของวาทศิลป์ Judith ( เพลงและบทกวีของ M. ) และเซเรเนดการเสียชีวิตของ Adonis ( เพลงของ M. , บทกวีของที่ไม่รู้จัก ) ใช้งานได้ดีมีความสุข ,ที่มีหลายจุดของการติดต่อพร้อมด้วยสไตล์แบบอิตาเลียนของ Handel ' ผ่านเข้าขวางของพ. garofoli นักวิชาการและ Borghese เดียวกันพร้อมด้วยซึ่งมันมีอยู่ในผู้ติดต่ออยู่ใกล้ถึงน้องชายของเขาที่เป็นนวตกรรมชิ้นงาน. M .รวมกันเพื่อ Arcadian Shores Academy ที่พร้อมด้วยชื่อของ driante sacreo (ตุลาคม 1711 )แล้ว livia Borghese m .ที่ส่งซ้ำหลายครั้งอย่างน้อยไปจนถึง 1714บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแตกต่างจากห้องพักรวมถึงลอร่าสิงห์และ duets เพื่อประโยชน์ของนักร้องที่ขนาดเล็กและ Virginia predieri .
2
4 บิดาเป็นมนุษย์คนหนึ่งของวัฒนธรรมที่กว้างที่ประกอบไปด้วยการเปรียบเทียบกับเล่นไวโอลินและแรงจูงใจ ภายใน ห้องนั่งเล่นพร้อมด้วยการแสดงดนตรี โดดเด่นไปด้วยในขณะที่ผ่านมาโด่งดังและขุนนางโบราณในเวลาที่ m .ครอบครัวให้แตะที่อาจเป็นหนึ่งในจุดต่ำสุดในชีวิตทางการเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ counterbalanced ในกรณีใดๆในระดับสูงที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะของ คุณแม่ที่ได้อุทิศให้กับวาด ภาพ และบทกวีเป็นเจ้าของโดยสาขาที่ครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากและมีอิทธิพลต่อคนรวยโฮมเธียเตอร์ได้. S . S .ทูตที่นั่งสำคัญของการแสดงเกี่ยวกับละครร้องในเมืองทะเลสาบได้ พี่น้องสองคนนี้ของ M .อเล็กซานเดอร์และเจอโรมได้รับผลประโยชน์ทางด้านวรรณกรรมได้เป็นอย่างมาก จากเกาะ สภาพแวดล้อม ที่คุ้นเคยกันดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดจึงเป็นจำนวนมากตามรอยของความเป็นตัวตนของมนุษย์และความงดงามทางศิลปะ m .ความปรารถนาของโฮมเธียเตอร์และเพลงที่น่าสนใจลึกบทกวีคงแก่เรียนวรรณกรรมที่มีไฟส่องสว่างระดับความไวทางศาสนาเป็นความ ภาคภูมิใจ ของเป็นของชนชั้นสูง Venetian .
ตามบรรดาผู้เขียนชีวประวัติต่างๆช่วงแรกๆที่บิดาของ M .ดูแลว่าทั้งสามคนที่จะใช้เป็นอย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มบทกวีอิตาเลียนอายุและในการนี้เขาเขียนอีเมลสำหรับเด็กในทุกๆเช้าสิบแปดหรือบทกวี M .ที่เริ่มในการศึกษาของสีไวโอลินแต่พร้อมด้วยผลในครั้งแรกที่ไม่ยกยอเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยัง รายงาน
วิทยาศาตร์ที่สิบแปดที่เจ้าหญิงของนิวบรันสวิกเยี่ยมชมพระราชวังที่วันหนึ่งของ Marcello ใน La maddalena ที่มากขึ้นของพี่น้องที่นวตกรรมชิ้นงานที่นำเสนอด้วยการจัดองค์ประกอบของภาพประจำสัปดาห์อนึ่งเสียงร้องและอินสทรูเมนทัลได้ มีสังเกตเห็นว่าน้องชายคนที่สูงศักดิ์โบสถ์ต่างๆของอเล็กซานเดอร์เพื่อจัดการกับสิ่งที่ได้รับในการตอบสนองและ M. ว่าเด็กจะอยู่ที่ด้านล่างของประเภทการ์ด gegan สูงสุดที่จะฟังเพลงได้ การบาดเจ็บที่ตกอยู่ในความรักของตนเอง , การตัดสินใจที่จะอุทิศตัวของเขาเอง . เอ็ม . เพื่อการศึกษาของเพลงที่มีกำลังต้านทานการดึงและมีความเหนียวเป็นพิเศษและการบำเพ็ญความเพียร ( ไดรเวอร์Fontana p . 3 ).
แม้ว่าจะไม่มีการข่าวได้อย่างถูกต้องสามารถสันนิษฐานได้ว่า m .ที่ได้รับมอบหมายให้วิทยาลัยของ somascan บรรพบุรุษกับอันโตนิโอ di สวยงามและ Castello Sforzesco ไม่ไกลนัก ต่อมาช่วงอายุสิบเจ็ดยี่สิบปีและดิ่งลึกลงการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเพลงและทฤษฎีที่ profondendovi ความมุ่งมั่นที่เคร่งครัดดังนั้นจากเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ของเขาเองในการแสดงดนตรีการฝึกอบรมเป็นคู่มือการเขียนข้อความ lucchese F. Gasparini กล่าวว่าการเขียนและการร้องประสานเสียงโอเปร่าที่โรงพยาบาลต้นแบบของความเลื่อมใสของ Venice เพื่อประสบการณ์การสอนที่ยังได้รับความไว้วางใจ D. Scarlatti ได้ อาจเป็นครั้งแรกของการเขียนความเรียงต่างๆได้ถูกอุทิศให้กับการ M. เข้มงวดที่สุดของแอปพลิเคชัน contrapuntal ( คิดค่าธรรมเนียมและทุบายนั้นเติบกล้าปลอม )ในขณะที่การบรรเลงในขั้นตอนการฝึกไวโอลินกับฮาร์พซิคอร์ดได้ อยู่ในที่ตั้งเดียวกันกับปีที่ผ่านมาก็เริ่มที่อ่านได้ของงานเขียนต่างๆของทฤษฎี G. Zarlino ถัดไปเพื่อการศึกษาของ Great masters คะแนนของอดีต - G. Pierluigi da C. Gesualdo โครงเรื่อง . ความ , C Monteverdi G. Frescobaldi G. เรียน - ขึ้นไปที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น A Stradella G. Legrenzi G. B Lulli , M - A Charpentier , H. Purcell , BCorelli Pasquini และ A ได้
2
4 แม้จะมีความโน้มเอียงในการเรียนดนตรีที่ยากต่อการคาดเดาให้เริ่มการ . เอ็ม . การอาชีพทางการเมืองซึ่งรวมอยู่ในสายเลือดขุนนางของเขาสำหรับแต่ละอันดับที่ใช้ที่แตกต่างกันในสาธารณรัฐ magistracies ของ เขาเริ่มฝึกวิชาชีพและทำให้ลักษณะที่ปรากฏเป็นครั้งแรกของเขาในเดือนเมษายน 1707 แล้วให้ togata หนึ่งเดือนหลังจากการเสียชีวิตของบิดาของเขา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีแล้วเขาได้โชคชะตา Bale ที่เรียกกันว่าของสีทองทั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่สามารถเข้าสู่ล่วงหน้าในคณะมนตรีสูงสุด เขาได้รับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการกับ messetteria ( 29 ก.ย. 1711 )ผู้พิพากษาเพื่อ esaminador ( 4 มีนาคม 1714 ) ternary อย่างเป็นทางการเพื่อไปยัง Old ( 1 กรกฎาคม 1715 )เป็นสมาชิกของพลเรือน quarantia เก่า( 14 ก.พ. 1717 )สารวัตรในบริการรับส่งจาก Pula ( 28 มิถุนายน 1733 )แล้วเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเก่า( 25 ก.ย. 1735 )และสุดท้าย camerlengo ในค้า Brescia ( 5 ม.ค. 1738 ) โรงแรมแห่งนี้คือ honorum cursus จากโปรไฟล์ที่ไม่สูงมากดังนั้นที่ m .เหมือนกับที่อยู่ในอัตชีวประวัติแฟนตาซี dithyrambic eroicomica ( 1738 )โอดไม่มีนมที่เป็นประจำของระบบราชการที่ต้องใช้เวลานานมากก็มีประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆทางด้านวัฒนธรรมศิลปะ
ใน 1707 แล้วทำให้การเดินทางเพื่อไปยัง Florenceสถานที่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาได้พบ G /> ได้ Händel ได้ ตามที่เก่าแก่ที่สุดในเหมือนกัน Kissinger ปีที่จุดเริ่มต้นเป็นกวี librettist M. , โดยไม่ระบุชื่อในการประกาศต่อด้วยความสุจริตใจรับรู้ dramma musica ซึ่งได้แสดงไว้ในโฮมเธียเตอร์ในช่องสี่เหลี่ยมของ Vicenza ได้ การแทนที่จะเป็นครั้งแรกวันที่ 1708 คอลเลคชันเพลงในการพิมพ์ : 5 แห่งที่พร้อมด้วยการแสดงดนตรีในสิบสองสีไวโอลินและเชลโล obligato solo ,การเผยแพร่ใน Venice ที่เป็นฉันที่ op. มีให้เป็นที่น่าเสียดายที่ขาดหายไปบางส่วนของเงินต้นสีไวโอลิน ส่วนที่สองของคอนเสิร์ตก็ถอดสคริปต์เหล่านี้ไปยังเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดโดย J. S. Bach Dang ( BWV 981 ) อยู่ในหน้าแรกของรุ่นเดิมชื่อผู้เขียนจะปรากฏขึ้นในการลบตัวอักษรพร้อมด้วยลักษณะอันโดดเด่นของการตรวจสอบคุณสมบัติของ " Nobile Via Veneto มือสมัครเล่นของ contrapunto " . .
2
4 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและในเฟสแรกนี้ของอาชีพการงานที่เป็นกวีเพลงของ M. , มีความจริงใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับครอบครัวของ Villa Borghese โรมันในครอบครัวโดยเฉพาะที่พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรง Livia Spinola Borghese ซึ่งอยู่ระหว่างปี 1709 และ 1710 ได้รับการออกแบบเฉพาะตัวของวาทศิลป์ Judith ( เพลงและบทกวีของ M. ) และเซเรเนดการเสียชีวิตของ Adonis ( เพลงของ M. , บทกวีของที่ไม่รู้จัก ) ใช้งานได้ดีมีความสุข ,ที่มีหลายจุดของการติดต่อพร้อมด้วยสไตล์แบบอิตาเลียนของ Handel ' ผ่านเข้าขวางของพ. garofoli นักวิชาการและ Borghese เดียวกันพร้อมด้วยซึ่งมันมีอยู่ในผู้ติดต่ออยู่ใกล้ถึงน้องชายของเขาที่เป็นนวตกรรมชิ้นงาน. M .รวมกันเพื่อ Arcadian Shores Academy ที่พร้อมด้วยชื่อของ driante sacreo (ตุลาคม 1711 )แล้ว livia Borghese m .ที่ส่งซ้ำหลายครั้งอย่างน้อยไปจนถึง 1714บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแตกต่างจากห้องพักรวมถึงลอร่าสิงห์และ duets เพื่อประโยชน์ของนักร้องที่ขนาดเล็กและ Virginia predieri .
การแปล กรุณารอสักครู่..


ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- I thought
- อย่ากินอาหารที่ตัวเองทำเยอะ
- CEOs continue to receive bonuses while t
- Wedding
- It is possible, however, to specify cert
- Controlling such disease mainly depend o
- สวัสดี
- The rooms have an excellent view over th
- เสื้อในของเล่นเด็กศูนย์อาหาร
- La seule discrétion avec vou
- While at our company, his responsibiliti
- 提要题的突破
- Controlling such disease mainly depend o
- ตังระดับความหนักเบาผุู้หญิงไม่เกิน1.5
- Forgive me, please.
- Yes, let's laugh. 262 {i1}Ayioo, so pr
- ยกเว้นคุณคุยเรื่องงานในวันหยุด
- ฉันชื่อปอ
- you will always be a baby to me.
- Tablets
- หลายแผ่น
- บริษัท ของคุณต้องการที่จะจัดให้มีการประช
- คุณไม่ควรส่งเสียงดัง
- (กรณีที่จะลา < 4 ชั่วโมง จะพิจารณาให้เฉพ